Home Page / Percorsi / Secondo piano:
Animali selvatici
Strategie di difesa e di offesa nei confronti del mondo animale
I reperti di cultura materiale riguardanti i selvatici, che si conservano nel Museo Etnografico Dolomiti, sono quasi sempre strumenti di costrizione o di morte: trappole e tagliole posizionate nei luoghi di passaggio, nelle soffitte e nelle cantine, negli orti, vicino ai pollai, provocavano la cattura e la morte degli animali (volpi, tassi, faine, topi, talpe), alcuni dei quali venivano cacciati sistematicamente per ricavarne pelli da vendere; gabbie e gabbiette di varie forme e dimensioni per gli uccelli da richiamo o da compagnia.
Proteggere lo spazio agrario e gli animali domestici dalle aggressioni dei nocivi era la motivazione primaria che spingeva i contadini bellunesi a mettere in atto anche altre strategie difensive: spaventapasseri, inefficaci guardiani di campi e orti, ma importanti sul piano simbolico; campanacci appesi alle viti o vecchie lame di falce che producevano rumore; spargimento di sostanze sgradite come il letame suino intorno ai campi di mais per scoraggiare le incursioni del tasso.
La caccia vera e propria si basava su presupposti diversi: l’uccisione dell’animale, sotto forma di prelievo (rane, lumache, gamberi di fiume, uccelli nel nido), o attraverso tecniche e strumentazioni più complesse, era finalizzata, seppur limitatamente, ad arricchire la dieta quotidiana.
Nelle zone di Livinallongo e Ampezzo, che hanno fortemente risentito dell’influenza austriaca, non si cacciavano gli uccelli di piccola taglia, in osservanza alle numerose leggi promulgate per abolire l’uccellagione nelle diverse province dell’Impero austro-ungarico.
Altre erano le motivazioni alla base della caccia “sportiva”, effettuata con armi da fuoco e con l’ausilio dei cani. Spesso riservata alle classi più abbienti, anche per i costi che implicava, aveva una valenza soprattutto ludica, finalizzata anche all’ottenimento di un trofeo da esibire. La caccia alla lepre, al camoscio, alla pernice bianca è stata progressivamente soppiantata da quella al capriolo e al cervo, che assieme ai mufloni, di recente introduzione nell’area del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, trovano oggi le condizioni ambientali più idonee al loro sviluppo.


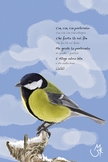


Sempre nella sezione “Secondo piano”
La cura del bosco e l'uso alimentare e terapeutico della vegetazione spontanea
Lo sfruttamento scalare dei pascoli e la produzione del foraggio
Domesticazione e allevamento bovino
Il profumo del burro e del formaggio
Pendolari alla ricerca dell'erba
Un rapporto di complicità
Aggiornata lunedì 14 novembre 2022 a cura di Marco Zucco













